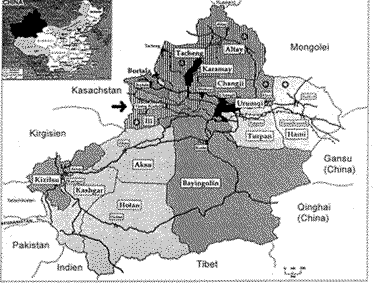Buttata lì così questa domanda potrebbe sembrare una di quelle da quiz televisivo del pre-cena, di quelle in cui ti trovi Mike Buongiorno o Gerry Scotti che ti traghettano fino al tg. Oppure, più sbrigativamente, qualcuno risponderebbe “e io che ne so?” e continuerebbe tranquillamente a guardare le vetrine per le vie del centro.
Eppure questa domanda – fatta da una persona dall'intelligenza decisamente acuta e che ha sempre spunti molto interessanti (per chi se lo stesse chiedendo: no, non sono io quella persona...) - ci pone davanti ad un problema che abbiamo già scordato, probabilmente presi nello zapping televisivo di fine agosto.
Questa domanda viene da una considerazione di un “mostro” come Jacques Attali (che io sinceramente vorrei come “eminenza grigia” della sinistra nostrana) su Internazionale, nella
 quale si diceva come non si debbano imputare i mali del mondo ad una alquanto folkloristica “teoria del complotto”, ma ad una decisamente più semplice perdita del controllo da parte dell'uomo dei sistemi da egli stesso creati.
quale si diceva come non si debbano imputare i mali del mondo ad una alquanto folkloristica “teoria del complotto”, ma ad una decisamente più semplice perdita del controllo da parte dell'uomo dei sistemi da egli stesso creati.E' proprio questo quel che nessuno, né ministri ex-mercatisti convertiti al no-globalismo come Tremonti (mi chiedo solo se davvero abbia capito cosa vuol dire essere un “no-global”) tantomeno i sancta sanctorum capitalisti, sta evidenziando: il modello di mondo che fino ad ora è stato pensato, ideato e messo in pratica sta passando a miglior vita. E' finito. Ma nessuno sembra volersene rendere conto. Il modello per cui per anni ci hanno fatto vivere sotto l'”effetto dotazione”, cioè sotto quell'effetto per cui più hai più sei, quel senso di accettazione della società non basato sul nostro “sapere”, sul nostro “essere”, ma sul nostro “apparire”, che in molti casi diventa “ostentare” non è più valido per le sfide che il terzo millennio ci chiama ad affrontare.
Se ci pensate – questo è un discorso un po' “folle”, me ne rendo perfettamente conto – questo modello si fonda su una convenzione. Niente di più, niente di meno. Questa convenzione, che è poi anche lo status con cui ti crei il tuo posto al sole nella società dell'illusorio, è il dio denaro. O meglio: è il significato che, per convenzione, da secoli diamo a dei semplici pezzi di carta. Con ciò non voglio dire che la soluzione migliore sia il ritorno al baratto, anche se ci vedo più di un vantaggio. Ma siamo ormai nel III millennio, ed ogni sistema nasce e muore in un tempo specifico. Però potremmo iniziare a dar meno importanza a quei pezzettini di carta. Potremmo iniziare a non considerare più la ricchezza individuale come il fulcro delle nostre esistenze sociali.
…Perché il nucleo del fallimento e dello sfruttamento dell’uomo sta nell’illusione di un’emancipazione culturale avvenuta attraverso il lavoro come bestie da soma e successivamente come consumatore provetto ed incanalato sull’odierno low-cost rovesciato sul mercato in abnormi quantità. [Marco Paolini]
E' questo, oggi, che dovremmo combattere. Come? Semplicemente creando un nuovo modello. Voglio dire: converrete con me – basta prendere un semplice libro di storia per rendersene conto – che tutti i modelli di società che la storia ci ha dato, dall'impero romano fino ai giorni nostri, hanno avuto una fase semi-ciclica basata sulle tre fasi della vita umana: nascita-sviluppo-morte. E così è anche in questo caso. Ma il problema, forse, non è " come cambiare le cose". Il punto è "cosa cambiare e in quale direzione".
Non ho velleità di dire che conosco il modello migliore per un fantomatico “nuovo mondo”, anche perché se lo conoscessi probabilmente non starei qui a scrivere su una tastiera. Però la direzione credo di poterla indicare. Andiamo a Sud. Precisamente in Sudamerica, da dove trovo ci siano molti modelli di sviluppo che potremmo analizzare. C'è una cosa che ho sempre adorato nel modo di fare politica dei sudamericani: il loro senso di "comunità", il loro senso di politica intesa come "solidarietà", come senso di appartenenza in un qualcosa che non premia mai - o quasi mai - il singolo. Se è una cosa fatta bene il merito è di tutti. Se è fatta male idem. Ed è proprio quando leggo le esperienze politiche dei sudamericani che mi chiedo se davvero un altro mondo sia possibile. Se guardo all'Occidente francamente mi viene da dubitarne. Come dice Angel Luis Lara:
"Il capitalismo è nato grazie a una enorme recinzione di terre, un immenso furto e saccheggio che fabbricò il proletariato, molti anni fa. La parola cultura è nata anch’essa moltissimi anni fa. Quando nacque, faceva parte di un’altra parola più grande:agricoltura. Non dimentichiamocene. Oggi più che mai è necessario che ci trasformiamo in contadine e contadini del comune."
Oggi più che mai è necessario che ci trasformiamo tutti in contadine e contadin
 i. Ciò non vuol dire solo un ritorno fisico alla Pachamama, alla Madre Terra. Non significa solo – ad esempio – cominciare a stare più attenti a quel che compriamo e a quel che quotidianamente portiamo in tavola. Fate questo piccolo esperimento, così capirete bene a cosa mi sto riferendo: andate in cucina aprite il frigorifero e fate la lista di quel che proviene da zone vicino a voi e di quel che proviene da lontano, da altre città o addirittura da altri continenti. Quasi sicuramente noterete una forte disparità tra quel che avrete acquistato “dietro l'angolo” e quel che si è fatto chilometri e chilometri in aereo (consumando quantità assurde di petrolio) per arrivare sulle vostre tavole. In questi ultimi anni sono venuti fuori almeno due concetti “rivoluzionario” per quanto riguarda questo aspetto e che però sono ancora visti come un qualcosa di strano, fatto da quelli un po' fuori di testa: “filiera corta” e “spesa a km zero”. Che in parole povere vuol dire comprare direttamente dal produttore e che possibilmente non abiti (od eserciti) la sua attività troppo lontano da casa nostra. Questo avrebbe nell'immediato due vantaggi: abbassamento dei prezzi ed abbattimento dell'uso del petrolio, con un sentito ringraziamento da parte del nostro pianeta (ed anche del portafogli...).
i. Ciò non vuol dire solo un ritorno fisico alla Pachamama, alla Madre Terra. Non significa solo – ad esempio – cominciare a stare più attenti a quel che compriamo e a quel che quotidianamente portiamo in tavola. Fate questo piccolo esperimento, così capirete bene a cosa mi sto riferendo: andate in cucina aprite il frigorifero e fate la lista di quel che proviene da zone vicino a voi e di quel che proviene da lontano, da altre città o addirittura da altri continenti. Quasi sicuramente noterete una forte disparità tra quel che avrete acquistato “dietro l'angolo” e quel che si è fatto chilometri e chilometri in aereo (consumando quantità assurde di petrolio) per arrivare sulle vostre tavole. In questi ultimi anni sono venuti fuori almeno due concetti “rivoluzionario” per quanto riguarda questo aspetto e che però sono ancora visti come un qualcosa di strano, fatto da quelli un po' fuori di testa: “filiera corta” e “spesa a km zero”. Che in parole povere vuol dire comprare direttamente dal produttore e che possibilmente non abiti (od eserciti) la sua attività troppo lontano da casa nostra. Questo avrebbe nell'immediato due vantaggi: abbassamento dei prezzi ed abbattimento dell'uso del petrolio, con un sentito ringraziamento da parte del nostro pianeta (ed anche del portafogli...).Questo localismo, qualcuno obietterà, nell'epoca della globalizzazione non è possibile. E forse tutti i torti non ce li ha. Ma se ci pensate, il poter avere tutto più o meno vicino ha anche un altro vantaggio: un maggior tempo libero. Che si trasforma in un maggior tempo da dedicare ai propri interessi, magari andando al parco a fare due chiacchiere o dedicandosi alla comunità in cui si vive. Ecco un altro aspetto che adoro dei sudamericani: il loro anteporre la comunità al singolo. Il loro considerarsi tutti pezzi necessari di uno stesso ingranaggio, di uno stesso progetto comune. Noi oggi invece – nati e cresciuti in una società individualista – a malapena salutiamo il nostro vicino di casa.
Interessarsi al bene della propria comunità, e quindi attivarsi per migliorarlo, vuol dire – in ultima analisi – attivarsi per il proprio bene, attivarsi per migliorare la propria condizione. Vuol dire agire su un qualcosa di globale (come appunto la comunità, intesa nella più generale accezione di “comunità-mondo”) attuando delle politiche locali. Vi faccio un esempio pratico: i No Tav. La loro lotta – lotta locale, ricordiamolo – per evitare che treni a 300 km/h gli transitino in salotto ha dei vantaggi per tutta la comunità, perché, ad esempio, bloccando quei lavori si evita di far traforare le montagne, di prosciugare piccoli fiumi o comunque altre deturpazioni ambientali, di cui un paese a forte cementificazione come il nostro non ha sicuramente bisogno. Globale e locale. Vi dice niente? Sommando globale e locale viene fuori un termine – che il nostro Ministro dell'Economia “no-global” dovrebbe per questo conoscere – che è “glocale”. Un termine che adoro e che ha una potenza semantica secondo me sconvolgente.
 Perché attuare dei modus vivendi glocali non riguarda solo quel che si mette in tavola, solo l'aspetto economico. Esiste un tipo di glocalismo "sociale", o "socio-politico" che dir si voglia, nel quale due concetti la fanno da padrone: rete e connessione. Intendendo così sia la rete che - ad esempio - mi permette scrivere su un blog, e che potrebbe essere utilizzata per digitalizzare (altra parolina magica) gran parte della nostra vita "cartacea" (giornali, comunicazioni dalla banca o da chi volete voi...); sia - soprattutto - come reti e connessioni tra persone. In questa ultima parte di articolo è venuta fuori un'altra parola “rivoluzionaria”: comunità (e senso di.).
Perché attuare dei modus vivendi glocali non riguarda solo quel che si mette in tavola, solo l'aspetto economico. Esiste un tipo di glocalismo "sociale", o "socio-politico" che dir si voglia, nel quale due concetti la fanno da padrone: rete e connessione. Intendendo così sia la rete che - ad esempio - mi permette scrivere su un blog, e che potrebbe essere utilizzata per digitalizzare (altra parolina magica) gran parte della nostra vita "cartacea" (giornali, comunicazioni dalla banca o da chi volete voi...); sia - soprattutto - come reti e connessioni tra persone. In questa ultima parte di articolo è venuta fuori un'altra parola “rivoluzionaria”: comunità (e senso di.).Ecco che qui già una risposta al “come fare?” iniziale la possiamo quantomeno abbozzare. Tornando alla comunità. Tornando a dar peso – sia in chiave sociale come abbiamo visto fin qui che in chiave politica – alla comunità. Abbiamo avuto un tempo un esempio perfetto di come la comunità possa auto-svilupparsi, senza seguire dei leader che tengano il timone. Perché anche il seguire un leader è, secondo me, uno degli effetti della società illusorio-individualistica nella quale viviamo. E' da un po' che mi pongo la domanda se davvero ve ne sia bisogno di “leader a condurre le masse”. E senza voler sfociare nell'anarchia alla Malatesta, direi che possiamo evitare di avere dei leader, ma ad un patto. Un patto che è la vera sfida dei tempi moderni: tornare ad interessarci attivamente a quel che ci circonda. E questa, nel mondo cresciuto a pane e telecomando, più che una missione difficile è una missione impossibile.